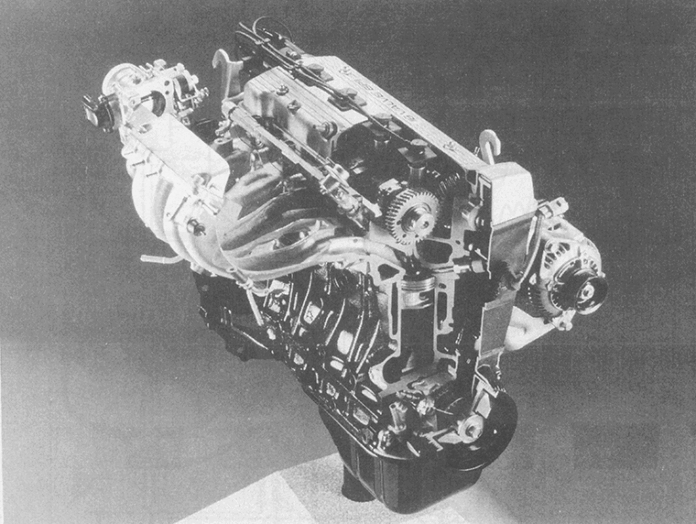Il “Green” è tutto uguale ma alcuni “Green” sono più uguali degli altri, avrebbe detto George Orwell.
La bibliografia sembra non voler riconoscere il requisito di “ecologismo” per tutto quello che appartiene all’era “A.B” (Ante BEV), che gli Evangeli di Watt fanno partire da due eventi apocalittici e didascalici che hanno cambiato il mondo.
Una è stata la prima apparizione della cometa “Roadster” proveniente dal Pianeta Elon nel 2007, e l’altro evento epocale è stato il buco nero di EPA che ha inghiottito tutta la costellazione sotto i cieli di Diesel.
Invece per i cattedratici di maniera, occorre ricordare che anche il settore Auto “pre” elettrificazione ha affrontato le sue belle questioni con consumo ed inquinamento.
E, con le armi che progressivamente la tecnologia ha messo a disposizione volta per volta, ogni Costruttore ha cercato di dare la sua soluzione lavorando con le sole variabili su cui era opportuno agire: aerodinamica, attriti volventi, materiali e tecniche costruttive “intorno” all’auto; e fluidodinamica, pressioni, temperature e rendimento termodinamico “dentro” l’auto. Cioè nel motore.
La base concettuale di tutto questo portava ad effetti diretti su tre fronti: riduzione delle masse in movimento, ottimizzazione dei flussi fluidodinamici, gestione affidata progressivamente all’elettronica, ed infine ricerca continua su nuovi materiali e nuove tecniche costruttive.
Un doveroso ricordo preliminare spetta però alla Volvo, prima casa al mondo ad adottare nel 1976 la “Sonda Lambda”.
E chi come me ha il suo bravo mezzo secolo ne ha sentite tante: ecco perché mi consentirete di articolare il mio più rapido possibile “Vademecum” storico e sinottico sulle evoluzioni e suidispositivi più significativi che ci ricordano come i Costruttori erano attenti a consumi ed ambiente anche nell’era preistorica dell’Endotermico.
Come primo Amarcord eccoVi in rassegna le principali soluzioni che da mezzo secolo o quaranta anni fa Burn, cioè i motori con miscela aria benzina “magra”. Un modo per rendere il ciclo di combustione più povero possibile di benzina. Un’impresa che può apparire semplice solo per chi è digiuno di meccanica.
Vi risveglio un ricordo di parole perdute: Rapporto Stechiometrico. Si tratta del rapporto ideale tra componenti di una miscela designata a compiere una reazione, che grazie a questo rapporto ideale avviene nel modo migliore raggiungendo perfettamente l’effetto desiderato.
Nel caso della miscela aria benzina l’obbiettivo di trasformare in energia motrice quella termica deriva dalla ottimale e più completa combustione della miscela stessa che, per conseguire l’effetto desiderato deve avere una proporzione ideale di una parte di benzina su 15 parti di aria. 1:15 appunto.
Sopra questa soglia, cioè con una minore presenza di aria rispetto alla benzina, la miscela “grassa” comporta effetti negativi che vanno da un consumo maggiore ed inutile di benzina, (fino alla fuoriuscita di carburante gassificato dalla marmitta con l’incendio e lo scoppio al contatto con l’aria esterna) alla emulsione con l’olio lubrificante fino al rischio di ingolfamento del motore; mentre con parti maggiori di aria, la miscela “magra” può comportare effetti di detonazione (preaccensione spontanea), di erosione delle pareti della camera di scoppio, di surriscaldamento, ma anche la riduzione del potere energetico a causa di “scoppi” meno vigorosi.
SUZUKI TSCC e lo “Swirl”: come darsi le arie …facendole girare
Ed ecco un filone di ricerca a cui sono particolarmente affezionato perché mostra davvero il genio ingegneristico alle prese con un mondo “oscuro” del funzionamento del motore: la fluidodinamica dentro la camera di scoppio. Perché alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, il “must” per i costruttori di motori – anche ad alte prestazioni – sembrò essere diventato non più il massimo riempimento volumetrico delle camere di combustione, ma il “come” riempirle.
La seconda crisi energetica di fine anni Settanta, unita al maggior rigore delle norme anti emissione USA, spostava l’interesse del pubblico e dunque dei Costruttori su due parole decisamente fuori rango per tutti: rendimento termodinamico e rapporto stechiometrico.
Nasce poi l’esigenza anche di rendere le moto più “di massa” nonostante le grandi prestazioni, per consentire loro un utilizzo più utilitaristico e professionale : questo significa dunque adattarle a modalità di funzionamento “friendly” su regimi di utilizzazione estesi, e di certo con i sistemi di carburazione doppio corpo ed accensione elettronica (struttura adottata dalla totalità delle maxi stradali del tempo) senza altro dispositivo, per rendere il motore omogeneo e “lungo” nella utilizzabilità non era così facile avere il motore “piatto” da almeno 3.000 fino a plausibili 9.000 Giri/min.
Si comincia perciò a lavorare sui “flussi” dell’aria, in ingresso ed in uscita: AirBox che cominciano ad avere sistemi di volumetria variabile a seconda del regime di funzionamento; ghigliottine e farfalle adattate su condotti di carburazione a sezione “ellittica” anziché circolare, e tutto per aumentare quello che potremmo chiamare “swirl”, cioè un moto elicoidale e non solo rettilineo e parallelo delle particelle di aria, in grado di “abbracciare” il più possibile il pulviscolo di benzina spruzzato dal carburatore senza pericolose disomogenie ed inevitabili “dislocamenti” di massa gassosa troppo agli estremi della camera di scoppio.
Si creava infatti, nella massa d’aria lineare, una naturale tendenza delle gocce di benzina a non emulsionarsi con il centro gassoso della colonna d’aria, ma una disposizione areolare che tendeva a condensare sulle pareti dei condotti o a generare accumulo di miscela infiammabile “lontano” dalla candela.
Quando non si lavorava a livello di “aria” in ingresso, per l’aria invece in “uscita” la ricerca costante lavorava su piegature, sezioni, e volumetrie dei condotti di scarico, prima ovviamente che le “valvole” parzializzatrici prendessero piede dalla seconda metà del decennio 1980.
Siamo alla fine degli anni Settanta, come detto: e pare che suscitare questo cosiddetto “vortice” di aria/carburante nella camera di combustione sia diventato di gran moda e come per ogni altro accorgimento ogni Costruttore aveva la sua brava sigla casalinga.
Suzuki aveva la sua nel “T.S.C.C.” (Twin Swirl Combustion Chamber), un brevetto appunto del 1979: anche per Lei Swirl, turbolenza, squish, quench, camere di combustione più piccole e rapporti di compressione più elevati con angoli delle valvole più stretti erano il nuovo “must” costruttivo.
Il “cuore” del concetto? Nessuna rischiosa “tasca” o “isola” nel cielo del Pistone né nella camera superiore di combustione; i dislivelli e gli spigoli presenti diventano in realtà gli “scivoli” da cui richiamare pericolose risacche di miscela incombusta e gli “svincoli” per dirigerla dove serve, cioè intorno alla candela e più vicino possibile alla valvola di scarico per accentuare la fuoriuscita dei Gas e non surriscaldare la zona di aspirazione aria, visto che tra l’altro la riduzione di volume e superficie della camera di scoppio evita la dispersione di calore per contatto.
In particolare il nuovo design motoristico della serie GSX 1979 dotata del T.S.C.C. non rielabora il cielo del pistone che rimane sostanzialmente “piatto”: ma modifica l’originaria camera di combustione a tetto spiovente con una “cresta” o colmo tra le sedi valvole. Il senso è quello di provocare non un incrocio tra i due flussi ma un moto circolare sia in senso orizzontale che verticale.
Cosa accade in ogni regime di rotazione del motore, ed in particolare agli alti ? Lo “Swirl” generato nella colonna gassosa comporta la maggiore vicinanza possibile alla candela di tutta la massa di miscela, senza dislocamenti di benzina in punti lontani.
Idealmente è come ognuno dei due flussi in uscita da ciascuna valvola di aspirazione si immettesse nella camera di scoppio secondo “spin” opposti andandola ad occupare in modo perfettamente omogeneo.
Questo permette di evitare preaccensioni malaugurate anche in caso di miscela “quasi” magra (indice stechiometrico < 1:15); mentre ai bassi regimi l’accelerazione imposta alla massa di aria propaga e diffonde la scintilla sulla quasi totalità della miscela presente nella camera di combustione: cosa che a basso regime, in presenza di poca massa d’aria e a rischio di scarsa mobilità e densità della carica, diventa impossibile.
Risultato immediato ottenuto da Suzuki?Il rispetto dei nuovi limiti anti-emissioni USA per la sua GSX-1100, la turistica da crociera perfetta per quel pubblico. Piccola nota a margine: vediamo adesso di seguito una serie diversa di applicazioni ed effetti voluti dallo “Swirl” specificatamente per ridurre la percentuale di benzina nella miscela con l’aria; ma nel caso della Suzuki il fine ultimo non era quello di avere miscele magre ma di miscelare meglio la benzina nebulizzata con l’aria dentro cilindri il più delle volte superquadri, con alesaggio (diametro dei cilindri) notevole.
Dato tuttavia ugualmente straordinario è che la sola modifica della testa con il disegno T.S.C.C. porta la serie GSX ad avere più potenza e coppia della serie GS che adotta identico motore ma vecchia testata!!
Sadao Shirasagi, l’Ingegnere capo cui fu affidato il compito di migliorare i motori GS750 e GS1000 per una nuova gamma di moto compatibile con i limiti USA e con minori consumi, aveva fatto centro. Lo stesso Shirasagi non mancò di ammettere una forte ispirazione avuta dal DFV Cosworth: quella sagomatura della testa del V8 Ford gli aveva trafitto la immaginazione, e fatto visualizzare il modus operandi.
Quelle due piccole camere a cupola incanalavano il flusso in due vortici circolari controllati, perché l’aria in compressione acquisisce proprio lo “Swirl” desiderato comprimendosi nella zona di squish (a forma di V) situata tra ciascuna serie di valvole.
Inutile dire che il TSCC aprì la strada ad un vero filone progettuale e costruttivo un po’ dappertutto, sia nelle due che nelle quattro ruote; ma con l’adozione degli iniettori orientati o della doppia accensione, diversi anni dopo, la sagoma a “doppia mezzaluna” (per dirla sbrigativamente) ha assunto più un canone industriale che non una continuata esigenza per le originarie motivazioni di Suzuki.
Ma rimane un grande progetto, che come tutti i colpi di genio mette insieme la assoluta semplicità di concetto e fase produttiva con il massimo risultato sperabile.
E poi, un plauso alla potenza creativa di Sadao Shirasagi: Lui, all’epoca, quel flusso e quel moto dell’aria se li è davvero potuti solo immaginare. Ma partendo dalla sua immaginazione ha creato uno dei motori più “puliti” ed efficienti. Con una idea geniale e semplicissima: quel “T.S.C.C.” che ha aperto la strada decine di brevetti similari su due e quattro ruote. Molto vicino alla Suzuki era il sistema brevettato da Ford per la motorizzazione 1400 cc di Escort ed Orion, ma in questo caso lo “Swirl” aveva il compito di supportate una vera “lean Combustion” di cui parlo di seguito.
CHT di Fiat Croma: e lo “Swirl” diventa un “mondo a parte” nel motore
Uno dei sistemi più impensabili? Il C.H.T. di Fiat montato sulla Croma “2.0” 90 Cv, dove creatività e pragmatismo danno vita ad un brevetto geniale: il CHT (Control High Turbolence) che consiste fondamentalmente in un sistema a due fasi differenziate attuate attraverso la posizione angolare di valvole a farfalla supplementari a valle di quelle “ordinarie” poste nei doppi corpi del carburatore.
Queste farfalle supplementari, poste ciascuna all’attacco di ciascun collettore di aspirazione con la testata attraverso un distanziale in specifica fusione (attraversata per la larghezza da un alberino cui sono collegate farfalle singole per ciascun condotto) “parzializzano” a seconda dell’inclinazione l’afflusso della miscela aria/benzina dentro il condotto opportunamente “sdoppiato” in due vie a sezione diffenziata: il condotto “convenzionale” o diretto – a diametro ordinario – è quello in cui la miscela aria/benzina passa classicamente quando il funzionamento del motore è a regime di utilizzazione previsto per le condizioni di marcia; ed in questo caso la farfalla supplementare è in posizione da parzialmente a totalmente aperta.
Quando invece il regime del motore oscilla tra minimo e regime sottocoppia la farfalla supplementare tende ad essere serrata chiudendo il condotto diretto verso la valvola di aspirazione; a questo punto la miscela si muove secondo il momento di depressione generata dal movimento lineare del pistone (come sempre) ma affluisce sopra la valvola di aspirazione attraverso un condotto ausiliario a sezione notevolmente ridotta che parte dal famoso distanziale sopradetto che si collega ad un “buchino” effettuato opportunamente sulla faccia laterale della testata fino alla parte superiore della sede valvola.
Il funzionamento come avete letto è facile da spiegare ma è abbastanza articolato, ed ovviamente si basa su un intelligente incrocio tra rotazione comandata meccanicamente (attraverso rinvii e bilancieri collegati alle farfalle del doppio corpo di cui è dotata la Croma CHT) ed anche depressori in ausilio alla “misurazione” angolare della posizione del pedale dell’acceleratore.
La riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni nocivenei motori endotermici passa anche attraverso l’utilizzo di ulterioritecniche:
emissione parzializzata del carburante escludendo l’afflusso ad alcuni iniettori nei sistemi multipoint e la parzializzazione – temporanea – della cubatura complessiva dei motori (preferibilmente con organizzazione dei cilindri a due bancate) con il taglio della alimentazione ad una delle due linee di cilindri.
Abolire i grassi…dalla carburazione: la “Lean Burn”
Come abbiamo anticipato ad inizio articolo, la miscela troppo “magra” sortisce a lungo termine effetti termodinamici e meccanici peggiori dei benefici registrabili su consumi ed inquinamento.
Tuttavia, se si tengono a bada questi aspetti negativi, il tenore quanto più possibile magro della miscela ha effetti positivi certi su consumi ed emissioni, ed in più sortisce un rendimento migliore del motore a regimi medio bassi.
Ebbene, come si sono mossi i principali Costruttori per gestire e sviluppare questa questione? Alcuni esempi, di diverse decine di anni fa:
Ford negli anni ’80 sviluppo’ una versione “Lean Burn” del CVH (a camera emisferica) da 1400 cc e 75 cavalli, dove la conformazione emisferica viene in questo caso interrotta da uno “scalino” che trasforma la sagoma emisferica in una pianta a forma di cuore, cioè a dire che la stessa camera di scoppio proietta ortogonalmente su almeno un terzo del cielo del pistone non un ambiente concavo ma un “soffitto” piatto complanare allo stesso cielo del pistone.
Il principio è in effetti identico a quello descritto prima per la Suzuki, ma in questo caso lo “Swirl” serve per aumentare la turbolenza non tanto per migliorare la combustione a regimi bassi e con minor volume di aria nel cilindro (come per la Casa giapponese) ma più che altro per aiutare la miscelazione della benzina in un rapporto che a seconda del regime di utilizzazione può arrivare anche a soglie di 1:18.
Chrysler dal 1976 al 1989 ha equipaggiato diversi motori con il suo sistema computerizzato ELB –Electronic Lean Burn, con cui si regolava “Just in time” la fasatura dell’accensione in base ai diversi sensori, sia nell’ambiente di aspirazione aria (per la depressione rilevata nel collettore di aspirazione, quello di rotazione dell’albero motore, quello della temperatura dell’aria in ingresso e del liquido di refrigerazione, e infine in base alla posizione angolare del pedale acceleratore); sia per l’ambiente di scarico dove, per ottemperare alle norme antiemissione molto severe negli USA, con il convertitore catalitico il sistema si completava con un sensore di ossigeno ed un carburatore a retroazione.
Toyota nel 1984 propone il suo motore 4A – ELU per il controllo del ciclo di combustione magra con apposito sensore di misurazione della miscela presente nel collettore di scarico per rilevare il tasso di miscela incombusta ed agire di conseguenza, secondo un sistema di iniezione parzializzato persino per ogni cilindro in base ad ulteriori sensori di temperatura localizzati in prossimità di ogni camera di scoppio.
Mitsubishi, infine (nel senso di ultimo esempio di questa rassegna)presenta nel 1991 il suo sistema “Mitsubishi Vertical Vortex” sul motore 4G15 (1500 cc, 4 cilindri in linea, 12 valvole con doppia valvola di aspirazione, di cui una sola invia miscela aria benzina che per l’effetto Venturi si miscela in modo perfetto prima di arrivare in camera di scoppio) che grazie alla colonna gassosa eccitata da un movimento vorticoso verticale ed alla candela posta vicino alla valvola di aspirazione che carica la miscela di aria e benzina può estremizzare il rapporto stechiometrico fino alla soglia incredibile di 1:25 con un regime di minimo che parte da solo 600 giri/min.
Ma l’elenco delle meraviglie che persino quaranta anni fa i Costruttori erano capaci di mettere in produzione non si ferma qui: e lo vedremo insieme nelle prossime occasioni.
Riccardo Bellumori